La Tavola del Silenzio
di Gian Franco Pinna
Era la notte che, è proprio la parola giusta, inghiottiva ottobre e vomitava il primo di novembre, quando l’aria nelle Dolomiti si faceva così sottile da sembrare ghiaccio rotto. Nel piccolo borgo di pietra e ombre della Valle che non c’è, la casa di Teresara non profumava certo di buon pane e vino, ma di terrore sussurrato. Non era una cena per i vivi. Era un tributo obbligato per ciò che non era più tra noi, non più “umano”.

Teresara, con movimenti lenti e innaturalmente precisi, tanto da sembrare soprannaturali, stendeva, invece della solita tovaglia, una tela grezza sul pesante tavolo di noce. Non accendeva una candela, ma un solo, tremolante cero che trasformava anche le ombre degli oggetti più innocui in minacciosi artigli.
I piatti erano scuri, disposti come occhi vuoti: una zuppa d’orzo torbida, fichi secchi raggrinziti come volti antichi, e un bicchiere di vin santo, rosso come un sacrificio. “È per Loro,” mormorava, la voce rauca, “perché stanotte devono trovare un posto dove riposare.”
I bambini non la guardavano. Erano paralizzati, il respiro bloccato in gola. “Ma i morti possono toccare?” balbettava il più piccolo, non per curiosità, ma per paura. Teresara non sorrideva; i suoi occhi erano pozzi scuri. “Non mangiano, prendono! E se li dimentichi, loro si ricordano di te.”
In quel gesto, tramandato per paura e superstizione, c’era sottomissione. “Poteva essere la malinconia per chi non c’è più a farla agire in quel modo, o è un modo per chiedere perdono?” pensava più di un bambino. Non potevano saperlo. I morti facevano paura: li guardavano nelle fotografie dei comò, sulle pareti, e i bambini si sentivano osservati. Ma non era paura, la loro… Erano presenze fredde, spiriti voraci che si credeva non camminassero, ma strisciassero tra le assi del pavimento, e la loro gelida presenza veniva avvertita sulla sedia accanto al fuoco perché non scaldava.
E così, passavano la notte di casa in casa per controllare che ovunque fosse tutto a posto. Con la scusa di chiedere qualche dolcetto e un lumino per la zucca, si assicuravano che in quella casa gli spiriti non portassero ombre e non prendessero nulla di diverso da ciò che era in tavola per loro. I bambini poi rientravano a casa stanchi e vinti dal sonno e non pensavano più a niente.
Gli altri vivi no. Nel borgo, ogni famiglia compiva il rito per placare queste anime della notte oscura. Alcuni lasciavano un secchio d’acqua stagnante fuori dalla porta per far sì che gli spiriti vi si specchiassero e non riconoscessero i vivi. Altri accendevano lumini sulle finestre per dire: “Passate oltre.” I più saggi andavano al cimitero, lasciando crisantemi che parevano lacrime secche, e tornavano a casa senza voltarsi indietro. Ma tutti, in casa loro e a modo loro, apparecchiavano la resa alla morte.
La mattina, la luce appariva debole e riluttante. Teresara raccoglieva i piatti intatti, spegneva il cero che si era consumato fino alla base, e con un sospiro di sollievo che suonava come una preghiera diceva: “Grazie per averci risparmiato.” Poi usciva. Camminava fino al camposanto e si fermava davanti alla tomba del marito. Non parlava. Ma aveva l’angosciante certezza che lui, o qualcosa che aveva la sua forma, l’avesse sentita.
Ognissanti è solo un nome. È un velo sottile tra le grida dei vivi e il silenzio dei non-morti. Un giorno in cui il tempo si squarcia senza far rumore, e i vivi capiscono di essere solo la prossima portata in una storia infinita, fatta di ossa, terra e polvere.




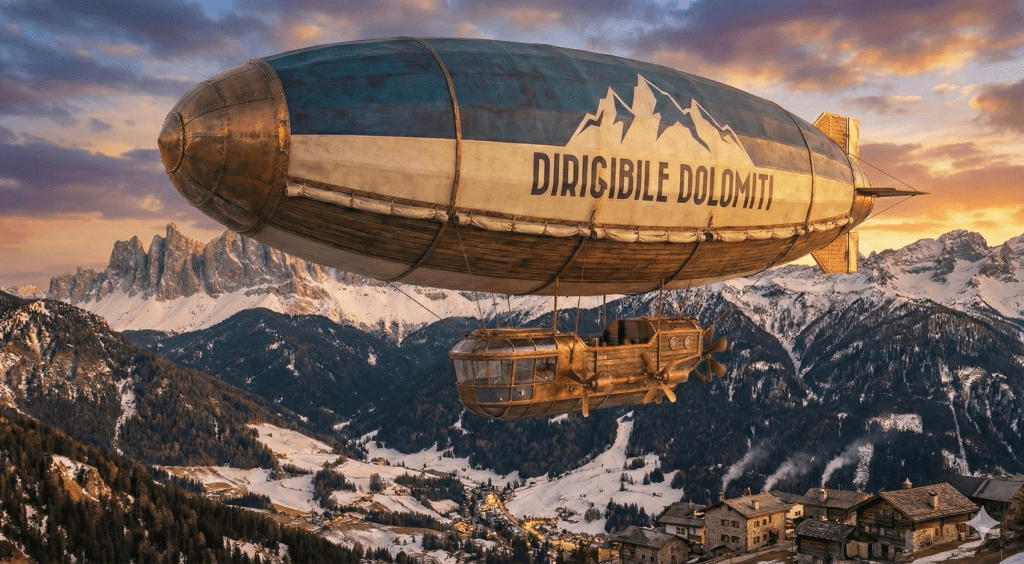
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.