oggi, 9 ottobre 2025.
Nel 2008 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite su iniziativa dell’UNESCO ha definito il disastro del Vajont come “il primo di 10 eventi disastrosi causati dalla scarsa comprensione delle scienze della terra e dal fallimento di ingegneri e geologi”, evidenziando la natura evitabile della tragedia. Nel 2023 l’UNESCO ha inserito l’Archivio del Processo del Disastro della Diga del Vajont nel Registro Internazionale “Memoria del mondo”. Questo riconoscimento mira a proteggere il patrimonio documentario di valore fondamentale per la ricostruzione e la difesa della memoria collettiva, e contemporaneamente il Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO ha riconosciuto che le Dolomiti sono un “luogo della memoria” per l’umanità, sottolineando la doppia natura del territorio come luogo di straordinaria bellezza e di grave disastro causato dall’uomo.
Questi sono fatti recenti. Ma il dopo Vajont non è sempre stato dalla parte delle vittime.
Già dalla stessa notte della tragedia, il fango rimasto in superficie e che ha cancellato la vita di circa 2000 persone e distrutto il futuro delle famiglie superstiti, è servito a nascondere trame che nulla hanno a che fare con la pietà e la giustizia.
Questa è la pietra miliare “Legge 4 novembre 1963 n. 1457” per chi ha voglia di leggerla.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
((Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno – quest’ultimo limitatamente alle località Borgo Piave, Lambioi e Lauta – della provincia di Belluno e nei comuni di Erto e Casso e Cimolais – quest’ultimo limitatamente alla zona ad occidente della sella di Sant’Osvaldo – della provincia di Udine è autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:
1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;
2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;
3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse col trasferimento degli abitati, nonché per studi, progettazioni e rilievi inerenti alla sistemazione della zona;
4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.
La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l’esercizio finanziario 1963-64)).
Prima parliamo di memoria. Come si tramanda. Cosa ci rimane. E non sarò breve.
Erano da poco passate le 22:00. Era tardi, più o meno la stessa ora in cui arrivai in stazione. Arrivai a Belluno la sera di un giorno d’ottobre, provenendo dalla stazione di Padova, dopo un lungo viaggio partito da Pallanza (Verbania). Ad attendermi c’era un tassista cadorino che mi avrebbe portato al piccolo paese nella Val Boite.
Salito in auto, feci subito la domanda di rito: “Quanto tempo per arrivare?”. Risposta: tre quarti d’ora. L’avevo chiesto perché non volevo far tardi. Mi aspettavano. Così li chiamai per avvisarli.
Durante l’uscita dalla città, che per la prima volta vedevo in vita mia, il tassista iniziò a darmi spiegazioni e nomi dei luoghi e dei monumenti che potevo ammirare lungo il percorso: il ponte degli Alpini, e così mi raccontò un po’ della città degli Alpini. Lasciammo Belluno, capoluogo delle Dolomiti (all’epoca non ancora UNESCO). “Conosci le Dolomiti?” — “Sì… incredibile, al mio paese in Sardegna, quando avevo 14 anni, la mamma di un amico era di San Candido e dipingeva montagne e flora delle sue amate valli, che io non conoscevo.”
A Ponte nelle Alpi, che ha una miriade di frazioni e un esteso territorio fino al Lago di Santa Croce — di cui in quel momento ignoravo l’esistenza, così come di Polpet — mi indicò la zona dove si trovava la casa dei Boito. Probabile intendesse altri della famiglia, mentre io pensai ad Arrigo, perché risposi: “Boito lo conosco!”. Dalla sua bella frase scoprii in seguito che era di Boccaccio: “Bocca baciata non perde ventura. Anzi rinnova come fa la luna.”
Dopo un piccolo, imbarazzante silenzio riprese: “Questo è il Piave, fiume Sacro alla Patria.” Quanta memoria, vedete… ma ormai eravamo a Longarone.
E anche lui si ricordò del Vajont solo in un momento quando, mentre percorrevamo la parte finale della salita che ci avrebbe portato verso il lato della stazione, notò il simbolo del Vajont. Quindi mi invitò a girarmi per osservare quella che “è la diga del Vajont… conosci il disastro di questo posto?”.
Il silenzio fu abbastanza lungo… Forse lui disse qualcosa, ma non ricordo. In quel momento vedevo la luce bluastra sul grande muro che chiudeva la valle, avvolta nell’oscurità che celava le montagne, e la mia mente rielaborò in poche frazioni di secondo tutto quello che sapevo, raccontatomi dai miei genitori.
Era successo di sera, ed era sera. Guardai l’orologio: le 22:32
Perché raccontare tutto questo? Perché la memoria viaggia così.
Passo per Longarone quotidianamente ma questa Memoria voluta per ricordare i morti del Disastro del Vajont non la vedo ogni giorno, ma solo alle celebrazioni. E le celebrazioni servono, si! E se non fosse stato per Paolini e il suo racconto teatrale nella famosa diretta di trent’anni fa, oggi chi saprebbe del Vajont? Dove sarebbe la Memoria? Come è stata tramandata la storia nei 34 anni prima di Paolini?!? La verità è che la Memoria, quella vera, quella scritta dalla natura, si è coperta dalla vergogna. L’unica visibile è quella diga che, reggendo, ha evitato un disastro ancora più mostruoso: la cancellazione totale della valle sottostante. Là, tra quella gola in lontananza, quando da un breve corridoio stradale passi per pochi secondi, puoi scorgere l’unico monumento che può riportare alla memoria quella tragica notte. Se entri in paese è un altro discorso. Ma se sei di passaggio, se non sai, non vedi. Già, perché l’altro monumento, il Campanile di Pirago, è nascosto da alberi cresciuti attorno per mascherare la vergogna. Nessuno lo nota in mezzo a quella boscaglia. Bisogna alzar la testa per scorgerlo tra i rami fitti. Un Monumento Nazionale che ormai non parla più a nessuno. Una Diga ben illuminata la notte, e un campanile ben nascosto dall’incuria decennale. Il Vajont… Non solo l’onda del ’63, ma il “secondo Vajont” è anche la tragedia del dopo.

Il Vero sciacallaggio.
L’incuria e il disinteresse delle cicatrici del Vajont forse non sono dovuti a negligenza, ma ad un segno di resa. Le forze e le energie per sopravvivere e soccorrere, sono diventate giorno dopo giorno, settimane dopo settimane, una flebile lotta contro chi ancora rigettava il fango sulla valle. Per capirlo, dobbiamo viverlo attraverso gli occhi di un sopravvissuto. Questo racconto denuncia il tradimento dello Stato e dei media, la speculazione economica sulle licenze e la violenza di una ricostruzione alienante. Una narrazione cruda sulla frattura definitiva tra le vittime e un’Italia che ha preferito l’affare alla verità.

Tutto iniziò con le parole, quelle stampate nero su bianco sui grandi giornali nazionali, che pesavano quasi quanto il fango che ci aveva appena sommerso. Avevamo ancora tutti nelle orecchie quel rumore indescrivibile dell’acqua e della terra che si menavano e si univano generando un urlo terreno che ancora risuona nella nostra testa. Nei giorni immediatamente successivi a quel 9 ottobre 1963, mentre noi cercavamo ancora i corpi dei nostri cari tra le macerie, si stava compiendo il primo atto di quello che avremmo poi chiamato il secondo Vajont. La narrazione ufficiale, quella che avrebbe dovuto raccontare il nostro dolore all’Italia, scelse invece di assolverci e condannarci allo stesso tempo. Lessi le frasi di Dino Buzzati sul Corriere della Sera, che con una prosa quasi divina parlava di un sasso caduto in un bicchiere, descrivendo la diga come un capolavoro e la natura come una matrigna crudele. Quella metafora poetica, apparentemente innocua, fu la prima pietra tombale sulla verità: trasformava un crimine industriale in una fatalità ineluttabile.
Ma non fu solo la poesia a ferirci. Fu la violenza politica di firme prestigiose come Indro Montanelli e l’atteggiamento di superiorità intellettuale di giornalisti come Giorgio Bocca a scavare il solco. Mentre Tina Merlin, la nostra unica voce, cercava di ricordare al mondo che quella tragedia era stata annunciata e denunciata per anni, la grande stampa la isolò, bollando chiunque cercasse le responsabilità umane con il marchio infame di “sciacallo”. Fu paradossale e doloroso: noi, che avevamo perso tutto per colpa dell’avidità altrui, venivamo accusati di speculazione politica solo perché chiedevamo giustizia e non accettavamo la favola del destino cinico e baro. Quell’etichetta, “sciacalli”, divenne il simbolo della nostra incomunicabilità con lo Stato.
Passata l’emergenza dei primi mesi, il fango si asciugò, ma al suo posto arrivò qualcosa di più insidioso: il denaro. La frattura tra noi superstiti e le istituzioni divenne incolmabile con l’approvazione della Legge 357 del 1964, la cosiddetta “Legge Vajont”. Quello che doveva essere lo strumento della nostra rinascita si trasformò nel meccanismo perfetto per la nostra spoliazione definitiva. La legge prevedeva che chi avesse perso un’attività commerciale o artigianale avesse diritto a finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per ripartire. Tuttavia, un dettaglio tecnico devastante permetteva la trasferibilità di questi diritti. Fu in quel momento che vedemmo arrivare i veri sciacalli.
Non erano giornalisti questa volta, ma affaristi, emissari di industrie del Pordenonese e del Trevigiano, uomini in giacca e cravatta che si aggiravano tra i prefabbricati dove vivevamo sfollati. Avvicinavano noi sopravvissuti, gente semplice, falegnami, osti, piccoli artigiani ancora sotto shock, e ci offrivano poche centinaia di migliaia di lire in contanti per comprare la nostra licenza, il nostro “diritto alla ricostruzione”. Molti di noi, stremati e convinti di non avere più un futuro imprenditoriale, vendettero. Non sapevamo che quei pezzi di carta, nelle mani di quegli imprenditori senza scrupoli, valevano miliardi di lire di finanziamenti pubblici. I fondi destinati a far risorgere la valle del Vajont finirono così per finanziare il decollo industriale di zone che non avevano mai visto nemmeno una goccia di quell’onda.
Mentre la ricchezza prendeva altre strade, noi subivamo anche la violenza urbanistica. La ricostruzione di Longarone fu affidata a piani regolatori calati dall’alto, come il piano Samonà, che disegnarono una città di cemento, fredda, razionale, estranea alla nostra memoria di pietre e legno. Non riconoscevamo più i luoghi della nostra infanzia. Ancora peggiore fu il destino di chi abitava a Erto e Casso: ci fu imposto un esodo forzato. Venne costruito il nuovo comune di Vajont, giù in pianura, vicino a Maniago. Presero noi montanari, abituati ai boschi e ai silenzi delle quote alte, e ci misero in schiere di case tutte uguali, in un ambiente piatto e anonimo. Fu una deportazione mascherata da aiuto umanitario. Molti anziani morirono poco dopo il trasferimento, non di malattia, ma di quella che noi chiamiamo la “morte per sradicamento”: si lasciarono andare perché l’anima era rimasta lassù.
Fu in questo clima di desolazione e raggiro che la rabbia prese il sopravvento sulla rassegnazione. Sui pochi muri rimasti in piedi o sulle pareti delle nuove costruzioni che non sentivamo nostre, iniziammo a scrivere la verità che i tribunali faticavano a pronunciare. Comparve la scritta “ASSASSINI”. Era rivolta alla SADE, ai dirigenti che sapevano e tacquero, ai controllori statali che chiusero gli occhi. E comparve anche la scritta “SCIACALLI”, ma questa volta non era un insulto che ricevevamo, bensì un’accusa che restituivamo al mittente: allo Stato e a quell’imprenditoria che banchettava sulla nostra morte.
Il secondo Vajont fu questo: la consapevolezza atroce che, mentre l’acqua ci aveva tolto la vita e le case, la ricostruzione ci stava togliendo la dignità e la memoria. Tina Merlin aveva ragione fin dall’inizio, ma la sua voce fu coperta dal rumore dei cantieri e dal fruscio delle banconote. Oggi so che la diga ha retto all’onda, ma è stato lo Stato a crollare sotto il peso delle sue responsabilità, lasciandoci soli tra il cemento nuovo e le vecchie ferite mai rimarginate.
Sciacalli e Assassini. La scritta sui muri e il doppio significato.
Mentre la parola “Sciacalli” fu usata dalla stampa a favore del progresso per zittire Tina Merlin (accusandola di speculare sui morti), a livello popolare e locale il termine fu ribaltato contro chi arrivò dopo per fare affari. Sui muri della zona apparvero scritte di rabbia (la più famosa e documentata fu però “ASSASSINI” rivolta ai responsabili SADE). La parola “Sciacalli”, non più quella scritta sui giornali, è corretto associarla alla compravendita delle licenze: la gente vedeva imprenditori estranei alla valle arrivare per comprare i diritti dei morti.
E qui entra in gioco La “Legge Vajont” (Legge n. 357 del 1964)
Il meccanismo dello scandalo fu innescato dalla Legge 31 maggio 1964, n. 357 (preceduta da decreti d’urgenza nel ’63). Questa legge, pensata per favorire la rinascita economica, conteneva un articolo fatale (art. 12 e seguenti) che permetteva la trasferibilità dei diritti.
Chi aveva un’attività nei paesi colpiti (artigianale, commerciale, industriale) prima del disastro aveva diritto a finanziamenti agevolati per riaprirla.
Il trucco vero tra i vari articoli della legge era quello che non obbligava a ricostruire nell’area interessata dalla distruzione, ma permetteva di vendere questo “diritto di ricostruzione” a terzi, che potevano utilizzarlo in tutto il Triveneto (comprensorio allargato).
Sulla carta i fondi erano per i sopravvissuti. In pratica, scoppiò un mercato delle licenze macabro.
Il meccanismo era semplice: Un artigiano sopravvissuto di Longarone che aveva perso tutto non aveva la forza o la voglia di rimettere in piedi un’azienda. Arrivavano “emissari” di grosse industrie venete o friulane e gli offrivano una cifra irrisoria (es. 50.000 lire o pochi milioni di allora) per comprare la sua licenza distrutta.
Il guadagno dello “sciacallo”: L’imprenditore esterno, con quella licenza in mano, andava dallo Stato e otteneva finanziamenti anche miliardari per aprire una fabbrica magari a Pordenone o Treviso, lontano dal Vajont. Del finanziamento ottenuto, il 20% era a fondo perduto e il restante da restituire ad un tasso di interesse agevolato per 15 anni, e ogni anno a una detassazione.
Le cifre dello scandaloso Secondo Vajont sono davvero rilevanti per l’epoca.
Gli Stanziamenti erano inizialmente di 10 miliardi di lire (Legge 1457/63), poi rifinanziati massicciamente con la Legge 357 e successive, arrivando a centinaia di miliardi di lire nel corso degli anni.
È documentato il caso di licenze pagate poche centinaia di migliaia di lire che hanno fruttato finanziamenti per centinaia di milioni. Si stima che miliardi di lire dell’epoca siano finiti a finanziare il decollo industriale del Nord-Est (fabbriche di mobili, elettrodomestici, ecc.) che nulla avevano a che fare con la tragedia.
Le radici dello scontro mediatico e il tradimento della politica
Per comprendere appieno come sia stato possibile il “secondo Vajont”, è meglio analizzare le motivazioni che spinsero stampa e politica ad assumere una posizione contro le vittime, trasformando un disastro industriale in una fatalità naturale. La stampa all’epoca viveva la divisione tra Tina Merlin e le grandi firme, che non fu solo una differenza di opinioni, ma lo specchio delle tensioni della Guerra Fredda e del boom economico:
- La lente metafisica (Dino Buzzati):
Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d’acqua e l’acqua è caduta sulla tovaglia. Solo che il bicchiere era alto centinaia di metri, il sasso era grande come una montagna e sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. Buzzati, bellunese, amava quelle montagne in modo viscerale. Per lui era culturalmente inaccettabile che la “sua” natura fosse stata stuprata dall’ingegneria. Preferì rifugiarsi in una lettura mitologica e rassicurante: la natura è un’entità misteriosa e ingovernabile. Assolvere la diga significava proteggere l’illusione che la montagna fosse ancora sacra e superiore all’uomo, rimuovendo lo sporco affare economico sottostante. - La trincea anticomunista (Indro Montanelli): Nel 1963, l’Italia era un campo di battaglia politico. La diga del Vajont era il gioiello della SADE, simbolo del capitalismo italiano e dell’industria privata (appena nazionalizzata). Per Montanelli, ammettere che la SADE aveva ucciso 2000 persone significava dare ragione al Partito Comunista e all’Unità. L’accusa di “sciacallaggio” verso la Merlin non era difesa della verità, ma difesa del sistema liberale contro l’attacco “rosso”. I morti passarono in secondo piano rispetto alla tenuta politica del Paese.
- L’abbàglio del progresso (Giorgio Bocca): Bocca incarnava l’Italia del Miracolo Economico, innamorata del cemento e dei grandi invasi. La sua colpa fu lo snobismo tecnocratico: si fidò della versione degli ingegneri (“la diga è perfetta”) perché considerava i valligiani e i loro timori come un residuo di un mondo contadino ignorante e superstizioso, destinato a scomparire di fronte alla modernità.
- Tina Merlin rappresenta il mito tra verità e lotta politica. PC contro DC. Scrisse su L’Unità tre articoli, l’ultimo nel 1961. Ebbe il coraggio e il merito di scrivere e far pubblicare ciò che davvero preoccupava la gente, a sostegno soprattutto degli ertani. All’inizio il giornale l’appoggiava. Poi qualcosa cambiò. Non sappiamo se ci furono pressioni all’interno del suo giornale o dall’esterno. Fatto sta che il suo ultimo articolo prima del disastro è del 1961. Subì un processo nel periodo precedente per “notizie false” e tendenziose per allarmare l’abitato di Erto. Con l’appoggio della popolazione vinse. Erto la notte della disgrazia, si salvò dall’essere spazzata via grazie al costone che la protesse dall’onda. Chi veramente subì l’onda furono altri centri abitati, e Longarone. Quest’ultima menzionata dalla Merlin nel famoso articolo del 20 febbraio ‘61.
C’è una sottile differenza tra l’atteggiamento di Montanelli e quello di Bocca. Montanelli attaccò la Merlin attivamente e politicamente. Il suo “sciacalli” era un’arma ideologica (siamo in piena Guerra Fredda, la Merlin era comunista). Bocca peccò più di snobismo e fiducia cieca nella modernità. Non attaccò la Merlin con la stessa ferocia, semplicemente la ignorò perché, per un grande inviato di un giornale moderno, era inconcepibile che “i montanari” e una cronista di provincia ne sapessero più dei grandi professori e ingegneri. La sua colpa fu l’arroganza intellettuale, quella di Montanelli fu la difesa politica del sistema. Bocca poi. in tempi più lunghi, ritrattò. Si rese conto dell’abbàglio.
Il favoreggiamento politico: Le parole del Potere (1963-1964)
La politica non si limitò a tacere: costruì attivamente la via di fuga per i responsabili. Le dichiarazioni e i comportamenti dei vertici dello Stato nei giorni successivi al disastro aprono ad una versione difensiva precisa.
- Il Presidente della Repubblica, Antonio Segni arrivando sul luogo del disastro, pronunciò parole che divennero la pietra angolare della difesa della SADE, la Società Adriatica di Elettricità, ideatrice e costruttrice delle opere di tutto il Vajont: «È una sciagura naturale, l’evento ha superato ogni umana previsione». Con questa frase, a metà tra la consapevolezza umana e la finezza della politica, la più alta carica dello Stato legittimò immediatamente la tesi dell’imprevedibilità, chiudendo moralmente il caso prima ancora che si aprissero le indagini.
- Il Presidente del Consiglio, Giovanni Leone rappresenta il cortocircuito più doloroso tra Stato e vittime. Leone visitò Longarone pochi giorni dopo la tragedia, promettendo ai superstiti: «Giustizia, non carità». Ma pochi anni dopo, dismessi i panni di Presidente del Consiglio, Giovanni Leone divenne il capo del collegio difensivo degli imputati SADE/ENEL nel processo penale. L’uomo che aveva promesso giustizia alle vittime finì per usare la sua abilità legale e il suo peso politico per difendere i carnefici, sostenendo la tesi che la frana non fosse prevedibile. Ma ancora peggio, trovò il modo di limitare i risarcimenti alle vittime: una macchia che non ostacolerà la sua ascesa al Colle.
- L’Enel e la SADE non fecero ammissioni di colpa. La strategia fu quella di finanziare studi geologici retroattivi (affidati a luminari stranieri) per dimostrare che la frana si era mossa su uno strato argilloso impossibile da rilevare con le tecnologie dell’epoca. Una menzogna tecnica smentita dalle perizie di parte civile (Floriano Calvino), ma che servì a trascinare i processi per anni.
Il “secondo Vajont” è il risultato di una convergenza di interessi: la stampa doveva salvare il mito del progresso, la politica doveva salvare la stabilità economica e industriale del Paese. In questo ingranaggio, la verità dei morti di Longarone era l’elemento da sacrificare. Per la seconda volta.
Gian Franco Pinna
Riporto la parte di una tesi del dott. Alessandro Sartori che troverete davvero interessante:
È Floriano Calvino, nel suo Vajont: genocidio dei poveri, a smantellare con lucidità tecnica il mito dell’imprevedibilità, riassumendo le conoscenze già disponibili prima del 9 ottobre. «Le dimensioni e l’unitarietà della massa franata erano perfettamente note», scrive Calvino, sottolineando come la velocità di caduta rientrasse nelle possibilità naturalistiche. Anche la risalita della frana sulla sponda opposta e il comportamento dell’onda erano logiche conseguenze delle condizioni morfologiche, nient’altro che la riproduzione su vasta scala di un evento «già verificatosi quattro anni prima nella stessa zona, sotto gli occhi delle medesime persone».
Con estrema chiarezza, Calvino spiega la dinamica fisica del disastro: la massa non fu frenata perché scivolò su materiali saturi d’acqua, ricevendo una «sottospinta idraulica» che ne sostenne il balzo verso la sponda destra, morfologicamente predisposta ad accoglierla con il minimo dispendio di energia. La dimostrazione è netta: l’intero meccanismo era prevedibile in base alle leggi della meccanica e della geologia applicata. Nulla del fenomeno fu davvero “eccezionale”, se non la sua colpevole sottovalutazione.
A questa rigorosa analisi tecnica fa eco la voce di Tina Merlin, la giornalista che più di ogni altro tentò di portare l’attenzione pubblica sulla paura degli abitanti e sui rischi della diga. Già nel 1960 denunciava su L’Unità il silenzio della SADE di fronte ai movimenti del monte Toc, notando come solo «gli operai e i contadini, guardando, capiscono che la montagna non dorme». Nel 1961, in un articolo poi raccolto in Sulla pelle viva, ribadiva con forza: «Il Vajont non è una fatalità. È un disegno umano tracciato sopra la pelle di chi non conta, di chi vive ai piedi delle montagne e non nei palazzi di Venezia o Roma».
Le sue denunce, ignorate e persino osteggiate dalle autorità (la giornalista fu querelata per “diffusione di notizie false e tendenziose”), rappresentano oggi un alto documento di etica civile e ambientale: una voce “profana” che anticipò di anni le conclusioni tecniche di geologi e tribunali.
Insieme, figure diversissime per ruolo e formazione come Müller, Semenza (il figlio Edoardo ndr), Calvino e Merlin formano il “fronte della prevedibilità”, uniti dalla capacità di leggere con realismo ciò che altri preferivano negare. Le loro analisi e le loro denunce dimostrano come la tragedia del Vajont non sia stata un errore di calcolo, ma una scelta consapevole di ignorare la scienza per motivi di profitto e prestigio.
Legenda delle fonti
- Lucia Vastano, “Vajont, due volte tragedia” (Liberazione, 9 ottobre 2002): «I superstiti che reclamavano giustizia erano fomentati da “sciacalli comunisti” che speculavano sul dolore e sui morti».
- Legge 31 maggio 1964, n. 357 (“Legge Vajont”): prevedeva contributi e trasferibilità dei diritti di ricostruzione, che favorirono speculazioni e spostamento dei fondi.
- Commissione parlamentare d’inchiesta sul disastro del Vajont (1964–1965): documentò responsabilità tecniche e amministrative, ma non impedì la percezione di insabbiamento.
- Dino Buzzati, “Natura crudele” (Corriere della Sera, 11 ottobre 1963): celebre metafora del bicchiere e del sasso, che trasformò la strage in fatalità.
- Indro Montanelli, “La Domenica del Corriere” (ottobre 1963): minimizzò le responsabilità umane, accusando di sciacallaggio chi chiedeva giustizia.
- Giorgio Bocca, “Il Giorno” (11 ottobre 1963): anch’egli collocò la tragedia nel registro della fatalità, isolando la voce di Merlin.
- Tina Merlin, articoli su L’Unità (1959–1963): denunciò i rischi della diga e fu processata per “diffusione di notizie false”, ma assolta.




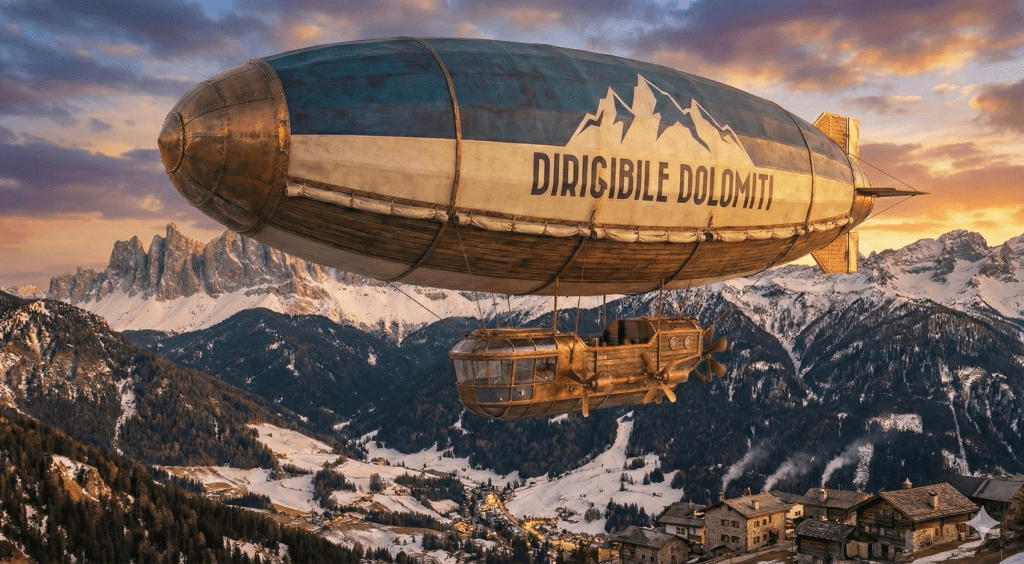
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.